Mia madre ricorda alla perfezione un pomeriggio di qualche estate fa, impegnato camminando nelle pieghe di Roma deserta, mescolati fra turisti accaldati e romani sbigottiti da routine quotidiane spezzate, ferie mal spese.
Due ragazzi stendono un telo vicino a Castel Sant’angelo. Una moto parcheggiata accanto, segni evidenti di battaglia con la strada, con la polvere ed il vento, la pioggia battente.
Fil di ferro a testimoniare riparazioni di fortuna: materiale povero e malleabile che cozza col ferro duro del mezzo ma che testimonia l’andare sempre e comunque, l’arte estrema di rimediare, proseguire.
Sul telo, con tratto confuso di pennarello in esaurimento, scritto in diverse lingue, un progetto di viaggio su e giù per il mondo in sella alla loro Honda Varadero. Chiedono soldi, offerte e la gente continua a domandarsi perché dovrebbe foraggiarli, qual’è il senso, dove la condivisione.
Forse, dentro, bolle una sopitissima invidia che non consente di evitare di etichettarli, di giudicare il progetto strampalato o sconsiderato, degno di una incoscienza puerile, propria di chi non è maturo.
Maturo per chi o cosa, questo no, non sarà mai chiaro però.
Mi madre me ne ha parlato qualche giorno fa ricordandomi una frase che forse credevo di non aver mai lasciato uscire dai denti. “Farò qualcosa di simile anche io”. Lo dissi alzandomi dal telo bianco, ormai grigio dall’asfalto delle città attraversate; alzandomi dopo aver passato le dita sulle strade tracciate alla buona, come a percorrerle mormorando via via i nomi delle nazioni.
Il loro era un sogno Sudamericano diventato europeo dopo aver contratto “la malattia”: l’andare. L’urgenza che sentivano dentro li spingeva ad andare, a confermare l’aver mollato tutto e tutti, ad allontanarsi sempre
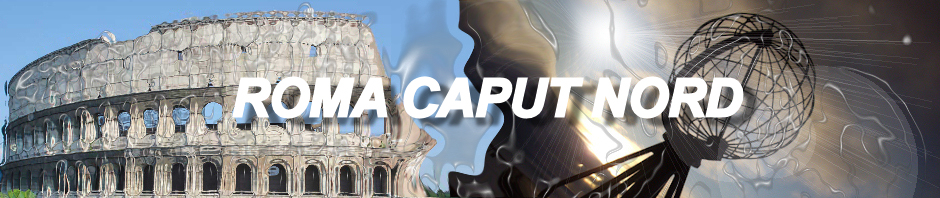



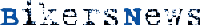 http://www.bikersnews.it
http://www.bikersnews.it